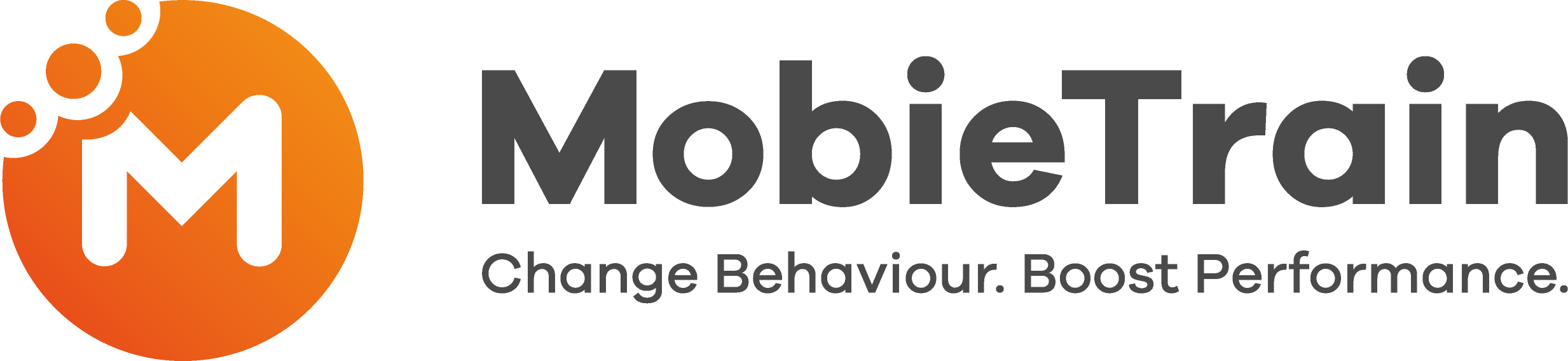Pane e formaggio. Due righe di storia
Nel "Regimen sanitatis scholae Salerni", codice dell’ XI secolo, colgo un cenno ai cibi molto nutritivi fra cui "Caseus orbatus, panisque recens oculatus": Il cacio privo di occhi e il pane fresco occhiuto.
E più oltre: "Caseus et panis, bonus est cibus hic bene sanis", Cacio e pane è buon cibo a quelli molto sani.
E utilizzerò questi occhi, questa attenzione alla salute dei consumatori, per guardare in un passato lontano un pane e formaggio che i medici stessi prescrivevano, con attenzione alla qualità dell’uno e dell’altro, e alle dosi. Un fatto è certo, il pecorino era considerato nutriente, mentre un cacio salato e invecchiato – purché non occhiuto – era ben visto in quanto stuzzicava lo stomaco. Approvato infine, anche il cacio insipido, insulsus, “che si digerisce bene e si scioglie”. Con questi brevi cenni, ne accogliamo la presenza per secoli e secoli, senza ripeterci con citazioni puntuali ed anche il “pane nero e formaggio” che un carbonaio consuma insieme ad un principe cacciatore, nella favola de "La Belle au bois dormant", La Bella addormentata nel bosco, di Perrault, apparirà consueto ed ovvio.
E i cuochi ? ovviamente non ignorano il pane e le sue preparazioni eleganti, e al formaggio dedicano precise valutazioni – Scappi, cuoco di papi, nel 1570 analizza tanto “i casci freschi” quanto quelli salati – ma non accade che pane e formaggio, sic et simpliciter, si accostino in cucina, se non in cotture studiate come quelle delle zuppe. Vincenzo Corrado viaggiando per il regno di Napoli e consegnando le sue note in un Notiziario del 1792, cita a Sorrento “i latticini, come butirri, ricotte, formaggetti, e fior di latte", e ad Amantea, in Calabria “formaggi diversi” ma nelle zuppe del Cuoco galante, il suo pane, a dadi, trova principalmente nel parmigiano un legame effettivo e saporito.
Pane e formaggio, o la stessa focaccia al formaggio citata dal Garzoni nella sua Piazza universale del 1585, sono il nutrimento semplice, di chi lavora, viaggia, vive senza servitù, con pochi denari, riempie di fretta la bisaccia o mendica affamato. Vincenzo Tanara, ne "L’economia del cittadino in villa" (1644) ribadisce : ”il cascio vecchio, vitto universale de faticanti gagliardi viaggianti, guerreggianti e simili”. Sino all'ultimo novecento, pane e formaggio (e vino) costituiscono il pranzo frugale, la merenda notturna, lo spuntino sempre pronto, una offerta caritatevole e l’espediente per cavarsi la fame al volo. Da quando diventano un cibo da buoni borghesi, che domanda una scelta, l’attenzione, e il servizio in tavola? Artusi, ne "La scienza in cucina", ultima edizione da lui curata 1911, non prevede nei suoi menu la degustazione dei formaggi. Ada Boni, nel "Talismano della felicità", dal 1925, fa un fugace cenno al solito formaggio servito in tavola e alle sue presentazioni eleganti in tartelette. Il servizio è codificato in Francia dal Larousse gastronomique, nel 1938: dopo arrosti e insalate, prima del dolce, i formaggi devono esser presentati in un singolo piatto ad ogni commensale, oppure offerti su un vassoio. Il burro, il pane, dei biscotti salati sono presenti in tavola, oltre a vini di pregio, Bourgogne o Bordeaux. In questo servizio, aveva fatto scuola il formaggiaio parigino Androuet, rue d’Amsterdam, il primo ad aprire, sopra il proprio negozio, un ristorante per neofiti e cultori.
Negli stessi anni, la "Guida gastronomica d’Italia" del Touring Club (1932) forniva nomi e localizzazioni, invitando il visitatore in provincia di Bergamo a richiedere, ad assaggiare: lo stracchino di Taleggio, il formaggio di Branzi, il bernardo di Clusone, le robiole, ognuna con la propria valle e il proprio alpeggio, le puine di capra e di pecora delle malghe della Val Seriana e della Val Brembana, le formaggelle piccanti di Val di Scalve, gli agri di Valtorta, il mascherpone e la mascherpa, sorta di ricotta magra e salata. La lista è lunga e si allungherà in riedizioni ed altre guide, di che far invidia ad un francese, anche se, dal nostro punto di vista, educati dalla scuola salernitana, manca il secondo elemento, e non v’è cenno ai pani. A Bergamo, piccola Parigi casearia, dominava la polenta.
Se poi, leggendo, andiamo a caccia di pane e formaggio in romanzi e novelle, la letteratura è ricchissima e ci permette di osservare gli individui che lo consumano, le donne che lo offrono. Limitandoci al XX° secolo, ritroviamo usi e appetiti singolari, tutti con una precisa rappresentazione, tale da far pensare che pane e formaggio è un copione dalle cento interpretazioni. Cominciamo da quelle che tradiscono più che l’indigenza, piccoli drammi familiari. In "Elias Portolu" di Grazia Deledda (1903) colgo queste parole, e protagonista è un pretuncolo:
“Una notte torno a casa dopo la mezzanotte. Mia sorella dice che ero ubriaco; ma a me pare di no, caro mio.“
- Cosa mi dai da cena, Anna?
- Nulla ti do, nulla, Jacu Maria Porcu, svergognato; mezzanotte è passata, nulla ti do.
- Dammi da cena, Annesa; ad un prete si deve dar da cena.
- Ebbene ti do pane e formaggio, svergognato, Jacu Maria Porcu, svergognato, mezzanotte è passata.
- Pane e formaggio ad un prete, a Jacu Maria Porcu?
- Sì, pane e formaggio, eccolo se lo vuoi, se no lascialo.
E per sottolineare il modesto valore di questo cibo varrebbe la pena di citare subito dopo un altro dramma domestico in "Cuore" di De Amicis (1886). Un ragazzo assiste il proprio padre gravemente malato, ed è tanto tanto assorto, addolorato che “appena sbocconcellava due volte al giorno un po’ di pane e un po’ di formaggio”. Così dolore e appetito potevano convivere con la giusta morale, ed era palese che era un nutrimento dettato dalle circostanze. Nelle "Novelle rusticane" di Verga (1880), troviamo invece pace e contento: “Comare Sidora gli mise dinanzi, su di un scanno, il pane caldo, colle olive nere, un pezzo di formaggio di pecora, e il fiasco di vino. E il poveraccio cominciò a mangiucchiare adagio adagio, seguitando a borbottare. – Il pane, osservò intenerito, come lo faceva la buonanima, nessuno lo sa fare. Pareva di semola addirittura!”. La Sardegna, la Sicilia, il Piemonte e potremmo continuare altrove nel Regno d’Italia, scene familiari tutte a tema.
Quando ritrovo buonumore, gusto per questo connubio? Lontano da campagne e monti, in tempi più recenti, nelle città, a Roma e nei "Racconti romani" di Moravia (1954). Così succede che alcuni amici, in gita sul lago di Bracciano, arrivino in una trattoria, e “anche qui non c’era nulla da mangiare, come a Marciano. Ordinammo fave fresche, pecorino, pane e vino... il formaggio era buono, forte, che pizzicava, il vino non era cattivo, pane e fave ce n’erano a volontà, e, così, ci rimpinzammo di pecorino, fave, pane e vino”. E' un’altra inquadratura, che permette di veder oltre il singolo consumo, introducendo, in loco, la fava. Ed infine "La bella di Lodi" di Arbasino (1960) – siamo in pieno boom economico e i consumi ne risentono – e si possono osservare alcuni giovani che vanno e vengono in una casa con camino, cucina e stanze al piano inferiore e superiore. “Nel salone grande, selezione di dischi di successo, un gruppo di cinque o sei, tutti addossati e seduti a un angolo solo del tavolo con dei plaids sulle spalle, mangiano dei formaggi e parlano di formaggi, passandosi assaggi e tasselli sulle punte dei coltelli:
- Ecco, senti, questo è il tipo di camembert che facciamo noi… Senti, per piacere la differenza col vostro… I padroni di casa sono italiani, e la Francia ha fatto scuola, con il camembert e il brie, il pane è entrato in un’altra fase epocale, quella di un tacito ed implicito servizio, la riscoperta dell’Italia casearia è ormai prossima e attende tutti loro il risotto al gorgonzola…
Opere citate:
Regimen sanitatis flos medicinae scholae Salerni, Salerno, 1973, 91
Jean Perrault, La belle au bois dormant, Contes, Parigi, 1989, 249
Bartolomeo Scappi, Opera, Venezia, 1570, 5
Vincenzo Corrado, Il cuoco galante, Napoli, 1786, terza edizione, 175
Vincenzo Corrado, Notiziario delle produzioni particolari del regno di Napoli, Bra, 2005, 49 e 71
Thomaso Garzoni, La piazza universale di tuttte le professioni del mondo, Venezia, 1610, 363
Larousse gastronomique, Parigi, 1938
Guida gastronomica d’Italia, Touring Club, Milano, 1932, 69-70
Grazia Deledda, Elias Portolu, 1903, Milano, Meridiani, 1971, 35
Edmondo De Amicis, Cuore, 1886, Milano, Meridiani, 1996, 209
Giovanni Verga, Novelle rusticane, 1880, Milano, Meridiani, 1987, 274
Alberto Moravia, Racconti romani, Milano, 1954, 362
Alberto Arbasino, La bella di Lodi, 1960, Milano, Meridiani, 2010, 595